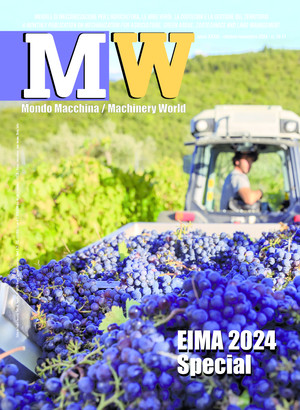La sostenibilità in risicoltura: sommersione e fertilizzazione
L’introduzione di un periodo aggiuntivo di asciutta (per diminuire le emissioni di metano) così come la fertilizzazione a rateo variabile consentono di ridurre l’impatto ambientale, ma anche di impiegare i fattori produttivi in modo più efficiente
La risicoltura ha da sempre rappresentato e rappresenta tuttora un’eccellenza del comparto agro-alimentare italiano; d’altra parte, l’Italia è leader a livello europeo per quanto riguarda la produzione di riso per risotti. Peraltro, anche a causa delle peculiari condizioni di coltivazione, l’impatto ambientale dovuto alla coltivazione del riso non è trascurabile. Infatti, la pratica della tradizionale sommersione continua crea condizioni di anossia nel suolo, favorendo la fermentazione anaerobica della sostanza organica e la conseguente emissione di metano, che può rappresentare una quota significativa (dal 40 al 55%) dell'impatto ambientale per la produzione di riso, per ciò che concerne l’impronta di carbonio.
L'uso di fertilizzanti azotati di sintesi è una pratica comune in moltissimi areali risicoli dove, generalmente, l’attività zootecnica è limitata e quindi anche la conseguente disponibilità di reflui. La produzione di questi fertilizzanti è però energivora, e la loro applicazione può portare a diversi problemi ambientali, tra cui la lisciviazione dei nitrati, la formazione di protossido di azoto (un altro gas serra) e la volatilizzazione di ammoniaca. Queste emissioni contribuiscono a fenomeni come l'acidificazione del suolo, l'eutrofizzazione delle acque dolci e marine, e la formazione di particolato atmosferico. Inoltre, un'eccessiva disponibilità di azoto può aumentare la suscettibilità delle colture a patogeni fungini. Le principali strategie per la mitigazione di questi impatti includono l’adozione di soluzioni di agricoltura di precisione (PA), in particolare attraverso la fertilizzazione azotata a rateo variabile (VR) così come l’ottimizzazione della sommersione con una gestione alternativa dell'acqua, che preveda asciutte aggiuntive in specifici momenti del ciclo colturale, come ad esempio, un'asciutta aggiuntiva a metà levata. La crescente attenzione da parte di tutti gli attori della filiera ha portato allo sviluppo di progetti di ricerca e di sperimentazioni che hanno fornito risultati interessanti. In questo contributo vengono presentati alcuni dei risultati del progetto RiceSmart (Tecnologie digitali per aumentare la sostenibilità e la competitività delle aziende risicole lombarde) finanziato dalla Regione Lombardia. La soluzione proposta prefigura nuove tecnologie digitali per la gestione sostenibile di concimi azotati, dei prodotti per il diserbo e della gestione della sommersione, e soddisfa le esigenze evidenziate dalla nuova PAC 2023-2027, poiché offre un supporto alle aziende agricole per migliorare le loro prestazioni ambientali e la competitività, soprattutto tramite un uso più efficiente delle risorse. Nel dettaglio, mediante l’impiego di un’applicazione per smartphone, è stato sperimentato un supporto alla fertilizzazione a rateo variabile, così come l’efficacia dell’introduzione di una asciutta aggiuntiva nel corso della levata.
Le prove di campo. Nel 2023 e 2024 per ogni azienda esaminata in Lomellina sono state eseguite prove specifiche in 4 campi sperimentali, così caratterizzati: nel primo la tecnica colturale praticata è stata quella classica (BASE); nel secondo è stata introdotta l’asciutta aggiuntiva a metà della fase di levata (con ri-sommersione entro inizio botticella) (A+); nel terzo è stata effettuata una fertilizzazione a rateo variabile (VR); nel quarto si è combinata l’asciutta aggiuntiva e la fertilizzazione a rateo variabile (A-VR). L’asciutta aggiuntiva durante la fase di levata consente di interrompere le condizioni di anaerobiosi del terreno e, quindi, comporta una riduzione delle emissioni di metano e parallelamente riduce gli assorbimenti di arsenico nella granella senza comportare aumenti significativi del contenuto in cadmio. Oltre a ciò, da un punto di vista organizzativo non comporta alcuna modifica del parco macchine aziendale. La fertilizzazione a rateo variabile, da un lato, permette un utilizzo più efficiente dei fertilizzanti che si traduce in una riduzione delle emissioni di composti azotati nell’ambiente e, quindi, dell’eutrofizzazione delle acque e dell’acidificazione del terreno ma, dall’altro, richiede la presenza di attrezzature specifiche nel parco macchine aziendali. Sono stati raccolti dati sui fattori produttivi distribuiti o consumati (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, combustibili) e sull’impiego delle macchine operatrici (tempi di lavoro, accoppiamenti macchina operatrice-trattore, vita utile delle attrezzature). Inoltre, al termine del ciclo colturale sono state misurate la resa in campo (tonnellate/ha di risone), l’umidità del risone e la resa alla successiva lavorazione.
Analisi del ciclo di vita. L’analisi dell’impatto ambientale è stata eseguita con il Life Cycle Assessment (Analisi del ciclo di vita) in accordo con le norme ISO 14040 e 14044. L’unità funzionale, ovvero l’unità per cui sono stati calcolati i diversi impatti, è una tonnellata di risone all’umidità commerciale (14%). Lo studio ha considerato tutte le lavorazioni svolte con i fattori produttivi impiegati (sementi, fertilizzanti, macchine agricole, ecc.), fino alla raccolta e all’essiccazione del prodotto.
Per le due varietà considerate, è possibile identificare qual è la soluzione con il minor impatto sul riscaldamento globale. In termini assoluti e relativamente all’impatto sul cambiamento climatico (impronta di carbonio), per la PVL024, l’impatto varia da 1033 kg di CO2 eq/t nel caso dello scenario Base a 575 kg di CO2 eq/t con l’asciutta aggiuntiva, a 859 kg di CO2 eq/t nel caso della fertilizzazione a rateo variabile e a 650 kg di CO2 eq/t nel caso in cui le due strategie di mitigazione vengano combinate. Analogamente per la Selenio, l’impatto varia da un massimo di 1195 kg di CO2 eq/t nello scenario BASE a un minimo di 682 kg di CO2 eq/t nel caso della tecnica colturale che prevede una asciutta aggiuntiva. In entrambi i casi a presentare l’impatto più basso è la soluzione che contempla l’asciutta aggiuntiva, seguita da quella che combina questa pratica con la fertilizzazione a rateo variabile e poi dalla tecnica colturale che è caratterizzata dalla fertilizzazione a rateo variabile.
Per la varietà Selenio, la soluzione che combina entrambe le strategie di mitigazione presenta un impatto superiore a quello dello scenario BASE, a causa di un calo della produttività della coltura. Tale riduzione comunque non appare direttamente collegata alla variazione della pratica colturale, ma dipende da altri fattori come un attacco di brusone, nel caso specifico.
Per quanto riguarda gli altri impatti ambientali valutati (es. acidificazione, eutrofizzazione delle acque e consumo di risorse minerali e fossili), i risultati evidenziano variazioni inferiori a quelle rilevate per l’impronta di carbonio. Per questi impatti, i benefici sono legati a due fattori ovvero ad un uso più efficiente dell’azoto, che comporta una riduzione delle perdite per lisciviazione e volatilizzazione, e ad una riduzione delle dosi applicate. è comunque interessante notare come per acidificazione ed eutrofizzazione, soprattutto nel caso del Selenio, le soluzioni che conseguono i migliori risultati sono quelle che prevedono la fertilizzazione a rateo variabile supportata dall’applicazione per smartphone. Sebbene quindi la variazione della produttività in campo possa arrivare ad annullare i benefici delle due soluzioni indagate, a parità di produzione, l’adozione della fertilizzazione a rateo variabile, così come l’introduzione dell’asciutta aggiuntiva, si confermano soluzioni in grado di migliorare la sostenibilità della coltivazione. Combinando modelli di simulazione, dati satellitari e misurazioni da smartphone, la soluzione sviluppata per la fertilizzazione a rateo variabile nel corso del progetto RiceSmart offre un supporto decisionale avanzato per ottimizzare la gestione degli apporti azotati, riducendo i sovradosaggi e le emissioni di composti azotati. Da tenere comunque presente che tale tecnica necessita di attrezzature e competenze specifiche non sempre disponibili soprattutto nelle aziende di dimensioni medio-piccole; senza dubbio l’introduzione dell’asciutta aggiuntiva si rivela più semplice e di immediata attuazione. L’efficacia di queste due tecniche di mitigazione dell’impatto ambientale così come di molte altre sviluppate e provate negli ultimi anni non può però prescindere dal mantenimento delle rese produttive. La riduzione delle produzioni di risone, oltre che avere conseguenze economiche negative, è in grado di annullare completamente anche i benefici ambientali derivanti dall’adozione dell’asciutta aggiuntiva e della fertilizzazione a rateo variabile.