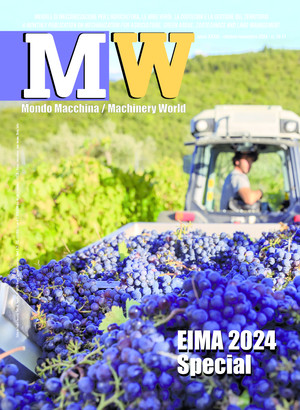Emissioni inquinanti: nuovi strumenti per il monitoraggio dei trattori
La road map sulla riduzione delle emissioni dei motori montati sui trattori agricoli è arrivata al livello Stage/TIER 5. Il rispetto di tale normativa è stabilito in base a cicli di lavoro predefiniti, che non rispecchiano adeguatamente le diverse realtà operative. Solo modelli predittivi dedicati possono dare indicazioni precise sull’entità dell’impatto ambientale
L'inquinamento atmosferico deriva da molteplici cause, ma sul banco degli imputati un posto di primo piano è senza dubbio occupato (a torto o a ragione che sia…) dalle emissioni gassose inquinanti dei veicoli dotati di motore endotermico, specie quelli alimentati con combustibili di origine fossile.
Già quasi 30 anni fa si è deciso di limitare tali emissioni, stabilendo di comune accordo in Europa e negli USA una “road map” che obbligasse i costruttori a produrre motori molto meno impattanti sull’ambiente. Da qui le normative denominate “Euro” (da 1 a 6, con suffissi), per i veicoli destinati a viaggiare su strada, e “Stage” e “TIER” per i mezzi da lavoro, includendo quindi in quest’ultimo caso anche quelli agricoli, ovvero trattori e operatrici semoventi.
Si è trattato di un percorso impegnativo, costoso e in alcuni passaggi complicato, ma dal risultato eclatante: si pensi che un trattore Stage V, che è il livello a cui devono essere conformi i motori installati sui modelli di nuova immissione sul mercato, emette solo il 2% circa dei gas inquinanti rispetto ad una macchina con un motore della medesima potenza, ma conforme allo Stage I. Ciò significa che un solo trattore Stage I inquina come 50 Stage V.
Se si pensa che il parco trattori in Italia ha, in media, un’età di oltre 25 anni, è facile immaginare come il ricambio di un mezzo datato con uno nuovo comporti un beneficio ambientale incalcolabile. Il rispetto di normative ambientali sempre più rigorose ha però imposto ai costruttori un impegnativo sviluppo tecnologico per il contenimento delle emissioni, che li ha portati da un lato a modificare i parametri di combustione del motore diesel, e dall’altro a prevedere dispositivi aggiuntivi a valle dei cilindri, per depurare i gas di scarico dalle componenti dannose (v. box).
Le normative e i cicli di funzionamento. La conformità ai vari livelli Stage e TIER è stabilita in base ad una serie di normative, messe a punto congiuntamente dalla Commissione Europea e dalla Environmental Protection Agency negli Stati Uniti, che si basano su un determinato (e presunto) uso standardizzato (i cosiddetti “cicli di funzionamento”) dei motori che equipaggiano i mezzi destinati all’uso fuoristrada (“non-road”).
Tale scelta è peraltro comprensibile, dato che solo in tal modo è possibile stabilire oggettivamente se un dato motore rispetta i requisiti voluti; inoltre, è possibile determinare immediatamente se un certo propulsore è migliore di un altro, poiché produce meno gas inquinanti.
Tuttavia, i cicli di funzionamento non sono quasi mai indicativi dell’effettivo uso di una macchina mobile fuoristrada, poiché tante e tanto varie possono essere le modalità di impiego.
Tale considerazione vale ancora di più per il trattore, che fa della versatilità d’uso il suo punto di forza.
Infatti, sono veramente numerose le variabili che possono influire in tal senso: in primis la durata del lavoro effettivo e la potenza mediamente impegnata, ma anche lo stato di usura del motore, il grado di manutenzione, la qualità del combustibile, lo stile di conduzione, ecc. E non è finita: in agricoltura, la varietà delle lavorazioni meccanizzate che possono essere svolte nell’ambito delle filiere produttive è veramente molto ampia; si deve poi tenere conto che il classico trattore agricolo è impiegato anche in numerosi altri settori paralleli, come quello forestale, della manutenzione del verde, della manutenzione stradale, del settore cava-cantiere, per lo sgombero della neve, ecc. Quindi, solo contestualizzando nella maniera più accurata possibile l’impiego di una certa macchina, sarebbe possibile determinare con sufficiente precisione l’effettivo impatto ambientale in termini di emissioni gassose inquinanti. Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano ci si è posti il problema illustrato, cercando di definire con il massimo grado di dettaglio quanto inquinano realmente i trattori in alcuni scenari tipici, con l’obiettivo finale di creare una serie di modelli per accertare, in una determinata situazione operativa, quale fosse il trattore più “risparmioso” e al contempo maggiormente rispettoso dell’ambiente. Inizialmente, ci si è concentrati sulla filiera viticola, sia perché le operazioni colturali sono in genere ben definite nel loro svolgimento e nei carichi di lavoro richiesti, sia perché i trattori impiegati sono di potenza medio-bassa, sui quali notoriamente è maggiormente sfidante mettere a punto motori poco inquinanti.
La procedura. A partire quindi dai cosiddetti “punti di funzionamento”, ovvero le condizioni di funzionamento (supposte costanti) del motore del trattore in una certa lavorazione, sono stati creati dei modelli della filiera accennata, attribuendo ad ogni operazione individuata una certa durata in ore, nell’ambito dell’intera stagione vegetativa.
Sulla base di questo scenario, è stato poi facile simulare, a punto fisso e con l’ausilio di un freno elettromagnetico, il carico di ogni lavorazione, per ricavare i dati voluti, ovvero coppia motrice, potenza e consumi specifici.
Contestualmente, in queste condizioni è stata misurata la quantità degli inquinanti prodotti, con particolare attenzione ai componenti di maggior impatto per i motori diesel, ovvero ossidi di azoto (NO e NO2) e particolato (PM).
L’efficienza dei motori … Ovviamente, anche a parità di conformità ai limiti di un determinato Stage emissivo, i propulsori montati sui trattori non sono tutti uguali, perché ognuno di essi è caratterizzato da valori diversi di efficienza, ovvero di consumo specifico (che è l’inverso diretto dell’efficienza). In pratica, viene evidenziata la capacità di trasformare in lavoro utile l’energia potenziale chimica contenuta in un combustibile, quando viene bruciato (insieme ad un comburente, che è l’ossigeno contenuto nell’aria) in un motore endotermico.
… e la quantità di gas inquinanti prodotta. Per evidenziare a colpo d’occhio le differenze prestazionali, è stato adottato un riferimento colorimetrico, la cosiddetta “logica semaforo” (impiegata spesso, ad esempio, per i fabbricati e per gli elettrodomestici), grazie alla quale sono stati confrontati i limiti normativi (misurati in termini di g/kWh, ovvero la massa in grammi di ogni inquinante rispetto all’energia sviluppata dal motore in chilowattora) con i valori sperimentali ottenuti.
Qualche risultato. A puro titolo di esempio, sono illustrati i risultati registrati – sia come consumo specifico che come inquinanti prodotti –- di alcuni trattori da vigneto, teoricamente impiegati nell’identico modo, in conformità ad uno scenario reale, in un’azienda vitivinicola basata su un’estensione colturale di 10 ha.
A parità di tutte le condizioni operative, le differenze riscontrate sono significative, specialmente per quelle lavorazioni che richiedono potenze limitate. I valori medi, pesati rispetto all’effettiva durata di impiego, variano tra 226 g/kWh per il modello più risparmioso e 303 g/kWh per quello meno efficiente, con un aumento di ben il 34%. Sulle singole operazioni il divario diventa talvolta anche più ampio: ad esempio, per la cimatura si va da 233 a 342 g/kWh, con un incremento di oltre il 46%. Del resto, la classificazione per codice colore rende oltremodo evidente le diverse condizioni, dove al trattore 2 viene attribuita la classe G (rosso), mentre il mezzo 4 si colloca brillantemente in classe A (verde). è quindi evidente che scegliere un trattore invece di un altro significa risparmiare notevolmente sulle spese di esercizio, almeno per ciò che concerne la voce “gasolio”. Se poi si pensa che questo modus operandi è di fatto replicato per un considerevole numero di anni, si può comprendere l’importanza della miglior scelta in termini di economia di esercizio del miglior modello di trattore nell’ambito dell’ampia offerta di mercato.
Anche per ciò che concerne l’aspetto ambientale vale la pena scegliere con attenzione il trattore più appropriato: già la conformità al livello emissivo condiziona molto la quantità di inquinanti gassosi emessi, ma la simulazione di un uso reale aggiunge ulteriori utili informazioni, e mostra anche qualche sorpresa. Va da sé che l’evoluzione tecnica del motore diesel degli ultimissimi decenni ha dato una grossa mano nel processo di riduzione degli inquinanti: l’introduzione generalizzata del controllo elettronico, dell’iniezione, del turbocompressore e ancora di più del common rail hanno migliorato enormemente la situazione, riducendo in special modo la produzione di idrocarburi incombusti e di particolato, ma con l’entrata in vigore di limiti emissivi sempre più restrittivi si è dovuto ricorrere ad ulteriori interventi tecnici.
Valutazione reale degli inquinanti. Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie a Ambientali dell’Università degli Studi di Milano sono stati applicati i modelli derivanti dai realistici scenari prima illustrati, confrontando poi le emissioni rilevate con i limiti normativi stabiliti dallo Stage (o TIER) di omologazione dei motori esaminati. Sempre con particolare riferimento ai modelli di trattore impiegati in vigneto, emerge una situazione in chiaroscuro, che vede ottimi risultati di contenimento per quegli inquinanti sui quali agiscono i dispositivi specifici, mentre sugli altri i limiti sono sforati, a volte abbondantemente. Se, infatti, è installato un motore con filtro antiparticolato, l’emissione di CO e PM è praticamente azzerata, ma l’HC e soprattutto gli NOx sono molto alti. La situazione opposta si verifica invece quando è installato il solo SCR, che limita molto bene gli NOx, ma non può intervenire validamente sul PM. A risolvere questa discrasia ci ha pensato il vigente livello normativo per i motori installati sui trattori, entrato in vigore di recente (Stage/TIER 5), per il rispetto del quale la maggioranza dei propulsori attualmente montati sui trattori agricoli di nuova immissione sul mercato deve essere necessariamente dotata di due (e a volte anche più…) dispositivi antinquinamento.
Modelli predittivi. Al di là dei limiti normativi, basati su cicli d’uso standardizzati, la progressiva messa a punto di modelli di impiego predittivi, aderenti alla propria realtà produttiva, potrà fornire preziose informazioni agli utenti, orientandoli validamente alla selezione del trattore più adatto alle proprie esigenze, con attenzione all’economicità di esercizio per ciò che concerne i consumi di combustibile, ma anche alla riduzione dell’impatto ambientale in tema di emissioni gassose inquinanti.
Strategie e dispositivi per la riduzione delle emissioni gassose inquinanti
A metà degli anni ’90 del secolo scorso sono state emanate specifiche normative parallele, denominate "TIER" in USA e "Stage” in Europa, per il progressivo abbattimento (a step successivi cadenzati nel tempo) delle emissioni gassose inquinanti prodotte dai motori endotermici, in relazione alla potenza massima del propulsore e al settore di applicazione. L’attenzione si è focalizzata su 4 sostanze, ovvero il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi incombusti (HC), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM). Per i motori a ciclo Diesel, è stato soprattutto importante contenere le emissioni di NOx e PM. Per abbattere gli inquinanti gassosi, si è agito sia limitandone la formazione in camera di combustione, sia soprattutto inserendo a valle del motore dei filtri di vario tipo, per bloccarli fisicamente, e/o dei catalizzatori per renderli chimicamente innocui. In realtà, di recente sempre più spesso si ricorre ad entrambe le strategie. E’ significativo sottolineare che il livello Stage V (Tier V), oggi richiesto per i motori installati sulle macchine agricole motrici e semoventi, ha ridotto l’impatto ambientale degli inquinanti citati fino ad un incredibile 98% rispetto ai motori Stage I, ovvero il limite in vigore inizialmente.
Modalità tecniche per la riduzione degli inquinanti
EGR (Exhaust Gas Recirculation)
Il ricircolo dei gas di scarico (EGR) è una soluzione che si basa sulla re-immissione di una parte dei fumi (circa il 5-15% in volume) in camera di combustione, abbassando in tal modo la temperatura di combustione e di conseguenza riducendo la produzione di NOx. Tale processo è realizzato di norma in modo esterno, grazie all’intercettazione di una quantità variabile dei gas di scarico, per mezzo di una valvola dedicata, gestita elettronicamente. I gas vengono quindi raffreddati tramite uno scambiatore di calore, al fine di ridurne la temperatura e quindi aumentarne la densità, e sono poi re-immessi nella camera di combustione insieme all’aria comburente.
SCR (Selective Catalytic Reduction)
Permette di abbattere molto efficacemente il livello degli NOx con un trattamento dei gas di scarico “ex-post”, cioè dopo la loro generazione, quindi senza interferire sulla combustione. All'interno di un catalizzatore, e con modalità controllate da una centralina elettronica dedicata, sul flusso dei fumi di scarico viene nebulizzata una soluzione acquosa di urea purissima al 32,5% (a livello commerciale definita spesso "AdBlue") che ad elevate temperature si dissocia, rilasciando ammoniaca. Quest’ultima, unitamente all'ossigeno, si combina nel catalizzatore con gli ossidi di azoto, a dare in uscita azoto atmosferico (non tossico) e acqua, sotto forma di vapore.
DPF (Diesel Particulate Filter)
Noto anche in lingua italiana come FAP (Filtro Anti Particolato), è un filtro fisico in materiale refrattario estremamente selettivo, che riesce a intrappolare sulla sezione tipica del suo reticolo gli agglomerati carboniosi. La pulizia periodica del DPF (definita “rigenerazione”) può essere passiva, avvenendo quando la temperatura dei fumi di scarico è particolamente alta, oppure attiva, con la modifica della combustione del gasolio, in modo da innalzare tale temperatura per innescare la combustione delle particelle carboniose intrappolate nel filtro, con la relativa riduzione in termini di dimensioni medie e la loro conseguente espulsione.
DOC (Diesel Oxidation Catalyst)
Il catalizzatore ossidante per diesel (DOC) agisce prevalentemente su idrocarburi incombusti (HC) e monossido di carbonio (CO), che vengono convertiti in CO2 e vapore acqueo. Il DOC è costituito da una matrice ceramica a nido d’ape, sulla quale viene depositato un sottile strato di metalli nobili (platino, palladio, rodio) che rivestono la vera funzione di catalizzatori, in modo da facilitare in tempi accelerati lo svolgersi delle opportune reazioni chimiche.